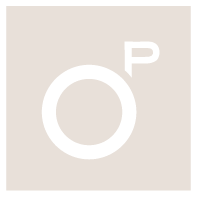Le Sezioni unite hanno affermato che il giudice d’appello del rito abbreviato, ove l’imputato sottoposto a misure restrittive non si sia rivolto al giudice competente per chiedere l’autorizzazione a recarsi in udienza o l’accompagnamento o la traduzione o questi non abbia dato l’autorizzazione, non può procedere allo svolgimento dell’udienza – sempre che gli sia comunque pervenuta a tempo la manifestazione di volontà dell’imputato di essere presente – e deve disporre la traduzione di quest’ultimo, a pena di nullità assoluta ed insanabile dell’udienza e della successiva pronunzia, ai sensi degli artt. 178, lett. c) e 179 cod. proc. pen.
(Cass. Sezioni Unite Penali, sentenza 24 giugno – 1 ottobre 2010, n. 35399)
Corte Suprema di Cassazione
Sezioni Unite Penali
Sentenza 24 giugno – 1 ottobre 2010, n. 35399
[OMISSIS]
1.1. Con sentenza 15 gennaio 2009, la corte d’appello di Napoli, sezione per i minorenni, confermò la sentenza emessa il 25 giugno 2008 dal tribunale per i minorenni di Napoli, che, a seguito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato F. F. colpevole del delitto di rapina aggravata in concorso con ignoti e lo aveva condannato, con la diminuente per l’età equivalente alle aggravanti e la riduzione per il rito, alla pena di anni due di reclusione ed Euro 300,00 di multa.
Osservò, tra l’altro, la corte d’appello che non poteva accogliersi la richiesta di applicare la continuazione con il reato oggetto della sentenza passata in giudicato il 20 giugno 2006, perché tale sentenza mancava in atti ed era quindi impossibile ricostruire le vicende e valutare la sussistenza di un originario programma criminoso, non essendo invero sufficiente a tal fine l’omogeneità delle norme di legge violate o la prossimità temporale dei fatti.
1.2. L’imputato propone ricorso per cassazione deducendo:
1) violazione dell’art. 599 cod. proc. pen., comma 2, art. 127 cod. proc. pen., commi 4 e 5, e art. 420 ter cod. proc. pen. e nullità assoluta della sentenza impugnata per essere stato disatteso il diritto dell’imputato, detenuto agli arresti domiciliari per altro, di partecipare al processo a suo carico. Ricorda che aveva chiesto di poter essere presente all’udienza mediante apposita istanza inviata via fax e pervenuta nella cancelleria della corte d’appello alle ore 16.26 del 14 gennaio 2009, giorno precedente a quello dell’udienza. La corte d’appello non ha concesso l’autorizzazione per motivi temporali ed ha poi rigettato anche l’istanza di rinvio avanzata dal difensore.
2) violazione dell’art. 603 cod. proc. pen., comma 3, e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in ordine al rigetto della richiesta di applicazione della continuazione con la sentenza divenuta irrevocabile il 20.6.2006 (emessa il 14.7.2005 dal Gup di Napoli e confermata in appello il 16.3.2006), relativa a fatti commessi il 23 febbraio 2005, e cioè poco più di cinque giorni dopo i fatti di cui al presente processo. Lamenta che erroneamente la corte d’appello ha respinto la richiesta per la mancanza di tale sentenza, omettendo però di considerare che la stessa era stata valutata dal giudice di primo grado, che aveva poi respinto la richiesta per motivi differenti. In ogni caso, tale documento ben poteva essere acquisito d’ufficio dal giudice ex art. 603 cod. proc. pen., anche perché esso era compiutamente e facilmente individuabile dalla mera lettura del certificato del casellario giudiziale.
3) mancanza assoluta di risposta e di motivazione sulla specifica richiesta, contenuta nei motivi di appello, di concessione del beneficio della sanzione sostitutiva della libertà controllata o semidetenzione, più idonea alla irroganda pena D.P.R. n. 448 del 1988, ex art. 30.
1.3. La seconda sezione penale – cui il ricorso era stato assegnato – con ordinanza del 9.3.2010, lo ha rimesso alle Sezioni Unite al fine di risolvere la questione, oggetto del secondo motivo di ricorso, se a carico dell’imputato che richieda l’applicazione della disciplina del reato continuato sussista o meno un onere di allegazione della sentenza cui si riferisce la richiesta ovvero sia invece sufficiente l’indicazione degli estremi della condanna.
Rileva l’ordinanza che, secondo un primo orientamento, l’onere di provare fatti, dai quali dipende l’applicazione della continuazione, è soddisfatto non solo con la produzione della copia della sentenza rilevante ai fini del richiesto riconoscimento, ma anche con la semplice indicazione degli estremi di essa, ben potendo in tale ipotesi l’acquisizione del documento essere disposta dal giudice, come si ricava tra l’altro dalla esplicita previsione dell’art. 186 disp. att. cod. proc. pen., che, pur riguardando l’applicazione della continuazione in sede di esecuzione, esprime un principio che ha valore generale.
L’orientamento prevalente è però in senso contrario, ritenendo che, ai fini del riconoscimento della continuazione in sede di giudizio di cognizione, costituisce un vero e proprio onere della prova a carico dell’imputato l’allegazione degli specifici elementi dai quali desumere l’unicità del disegno criminoso, non essendo invero applicabile in sede di cognizione l’art. 186 disp. att. cod. proc. pen.
L’ordinanza di rimessione ricorda anche che sotto la vigenza del vecchio codice di rito – nel quale mancava un referente normativo analogo all’art. 186 disp. att. cod. proc. pen. – la medesima questione era stata risolta dalle Sezioni Unite affermando che all’imputato che invoca l’applicazione della continuazione in relazione ad altri reati, oggetto di altri procedimenti, incombe l’onere della allegazione, il quale non è soddisfatto con la mera indicazione dei procedimenti, nei quali sono state pronunziate le sentenze, o degli estremi delle sentenze stesse, ma soltanto con la specifica allegazione, oltre che dei procedimenti, anche dei reati e degli elementi obiettivi e subiettivi, in base ai quali possa desumersi l’unicità del disegno criminoso. Osserva conclusivamente l’ordinanza di rimessione che non sembra azzardato presumere che il legislatore delegato, nell’introdurre la disciplina dettata dall’art. 186 disp. att. cod. proc. pen., abbia tenuto presenti gli approdi cui era pervenuta la giurisprudenza sul tema in esame.
1.4. Il Primo Presidente Aggiunto ha quindi assegnato il ricorso alle Sezioni Unite penali per la trattazione alla pubblica udienza del 24 giugno 2010.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. È preliminare l’esame del primo motivo, col quale si eccepisce la nullità del giudizio di secondo grado e della sentenza impugnata per essere stato violato il diritto dell’imputato di essere presente e partecipare al processo a suo carico.
Ritiene la Corte, conformemente alle considerazioni e conclusioni del Procuratore generale, che il motivo è fondato.
3. Sull’ambito del diritto dell’imputato detenuto (o sottoposto agli arresti domiciliari o ad altra misura limitativa della libertà personale) di partecipare al giudizio camerale d’appello avverso una sentenza pronunciata col rito abbreviato, vi sono state in passato alcune incertezze nella giurisprudenza di questa Corte.
Secondo un orientamento risalente e più restrittivo, poiché il giudizio di appello avverso sentenza pronunciata nel giudizio abbreviato ex art. 442 cod. proc. pen., si svolge in camera di consiglio in virtù del richiamo operato dall’art. 443 cod. proc. pen., ult. comma, all’art. 599 cod. proc. pen., e poiché l’art. 599 richiama a sua volta “le forme previste dall’art. 127” per la procedura camerale, dovrebbero applicarsi nella procedura in esame anche le norme dell’art. 127 relative alla partecipazione all’udienza del soggetto detenuto ed ai termini per fare la richiesta di comparire. Secondo questo più remoto orientamento, quindi, il diritto dell’imputato appellante detenuto (o sottoposto ad altra limitazione della libertà personale) di partecipare al giudizio camerale di appello sarebbe subordinato ad una duplice condizione: a) che egli sia ristretto nel medesimo distretto della corte d’appello, mentre se sia ristretto altrove avrebbe unicamente il diritto di essere sentito prima dell’udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo; b) che, in ogni caso, l’imputato abbia fatto alla corte d’appello richiesta di essere sentito osservando il termine stabilito dall’art. 127 cod. proc. pen., comma 2, ossia fino a cinque giorni prima dell’udienza (Sez. II, 5.7.1999, n. 9563, P., m. 214262; Sez. IV, 31.3.1998, n. 4366, L., m. 210456; Sez. II, 6.2.1998, n. 2950, G., m. 209946; Sez. I, 13.11.1995, n. 11894, G., m. 203235; Sez. I, 24.4.1995, n. 6665, V., m. 201533; Sez. VI, 31.5.1993, n. 7987, D. F., m. 194915; Sez. VI, 25.3.1993, n. 5313, A., m. 194376; Sez. VI, 30.10.1991, n. 176/92, S., m. 189414).
Questo orientamento – anche se recentemente ribadito da una isolata decisione (Sez. VI, 17.9.2009, n. 39675, O., m. 244777, ma con esclusivo richiamo alle tesi e massime più remote) – è stato però da circa un decennio superato da un diverso indirizzo, secondo il quale, invece, l’imputato detenuto, sempre che lo richieda, ha il diritto di presenziare al giudizio camerale di appello avverso la sentenza pronunciata in giudizio abbreviato, anche se non ricorrono le due condizioni dianzi indicate.
4. Ritengono le Sezioni Unite che, in mancanza di specifiche ed inequivoche disposizioni legislative in senso contrario, questa seconda soluzione interpretativa debba essere senz’altro preferita, in quanto il diritto fondamentale dell’imputato di essere presente nel giudizio camerale in cui si decide sulla sua responsabilità, è maggiormente assicurato se si esclude che esso sia strettamente subordinato alla presenza delle due suddette condizioni (detenzione nella stessa circoscrizione e presentazione della richiesta almeno cinque giorni prima dell’udienza).
Questa conclusione comunque si basa, innanzitutto, su una più rigorosa interpretazione letterale e sistematica della disposizione, specifica per il giudizio camerale in grado di appello, di cui all’art. 599 cod. proc. pen., comma 2, – secondo cui “l’udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell’imputato che ha manifestato la volontà di comparire” -, disposizione che non ripete l’inciso “e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice”, contenuto nell’art. 127 cod. proc. pen., comma 4, e che, in quanto norma speciale, deroga alla norma generale di cui all’art. 127 ed è quindi sulla stessa prevalente (Sez. I, 23.6.2006, n. 26276, S., m. 234419; Sez. V, 6.6.2002, n. 28867, R., m. 223100; Sez. II, 7.12.2001, n. 209/02, L., m. 220444; Sez. VI, 9.3.1998, n. 6384, O., m. 210906).
Questa interpretazione, inoltre, proprio perché garantisce maggiormente la partecipazione al giudizio di merito dell’imputato appellante, che abbia manifestato una volontà in tal senso, è più conforme ai principi del giusto processo e del contraddittorio, sanciti dall’art. 111 Cost., il quale riconosce la piena espansione del diritto di autodifesa e l’esercizio di facoltà, che solo la presenza dell’imputato nel processo è in grado di assicurare.
La detta interpretazione trova anche conferma sia nelle norme e principi posti dall’art. 6, comma 3, lett. c), d), e), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, i quali, nel prevedere il diritto di ogni accusato di difendersi personalmente, di esaminare o far esaminare i testimoni e di farsi assistere gratuitamente da un interprete, implicano necessariamente la presenza dell’imputato; sia nell’art. 14, comma 3, lett. d), e), f), del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato a Nuova York il 16 dicembre 1966, e reso esecutivo in Italia con L. 25 ottobre 1977, n. 881, che riconosce esplicitamente il diritto di ogni individuo accusato di un reato di essere presente al processo, oltre che di difendersi personalmente o mediante un difensore di sua scelta, di interrogare e fare interrogare testimoni, di farsi assistere gratuitamente da un interprete.
L’interpretazione stessa trova infine conforto nella sentenza della Corte costituzionale n. 45 del 1991, la quale, con riferimento al procedimento di riesame, ha chiarito l’assoluta importanza dell’instaurazione del contraddittorio di fronte al giudice che dovrà assumere la decisione ed ha riconosciuto che l’imputato detenuto è certamente titolare di un interesse ad essere presente all’udienza per contrastare, se lo voglia, le risultanze probatorie ed indicare eventualmente altre circostanze a lui favorevoli. D’altra parte, il diritto-dovere del giudice di sentire personalmente l’imputato, e il diritto di quest’ultimo di essere ascoltato dal giudice che dovrà giudicarlo, rientrano nei principi generali d’immediatezza e di oralità cui s’informa l’attuale sistema processuale.
Del resto, queste Sezioni Unite già con la sentenza 25.11.1995, n. 40, C., hanno sanzionato con la nullità assoluta ed insanabile dell’udienza e della pronunzia la mancata traduzione all’udienza di riesame della misura cautelare dell’indagato che ne abbia fatto richiesta, quand’anche detenuto in un’altra circoscrizione, sicché sarebbe manifestamente irrazionale ritenere che una tale rigorosa tutela del diritto al contraddittorio non si applichi anche nel giudizio camerale di appello dove è messa in discussione proprio la responsabilità dell’imputato, tanto più che la norma speciale per tale giudizio non contiene alcun riferimento al luogo di detenzione e a un termine di presentazione della domanda.
5. Sulla base della interpretazione che si condivide, quindi, deve innanzitutto escludersi che sia necessaria la prima delle due condizioni dianzi ricordate, ossia che l’imputato sia ristretto nella stessa circoscrizione del giudice. Va dunque ribadito il principio che l’imputato detenuto o soggetto a misure limitative della libertà, che manifesti in qualsiasi modo e tempestivamente la volontà di comparire, ha diritto di presenziare al giudizio camerale di appello avverso la sentenza pronunciata in giudizio abbreviato anche qualora sia ristretto in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice procedente (Sez. VI, 2.12.2009, n. 48557, S., m. 245657; Sez. I, 18.3.2009, n. 15137, B., m. 243732; Sez. I, 23.6.2006, n. 26276, S., m. 234419; Sez. I, 8.2.2006, n. 6970, M., m. 233440; Sez. II, 9.1.2003, n. 11756, B., m. 224905; Sez. V, 6.6.2002, n. 28867, R., m. 223100; Sez. VI, 29.1.2002, n. 21561, B., m. 222742; Sez. II, 7.12.2001, n. 209/02, L., m. 220444; Sez. VI, 29.1.1991, n. 7373, M., m. 187838).
6. Per le medesime ragioni deve anche escludersi che sia necessaria la seconda delle due condizioni indicate, ossia che la richiesta di essere presente in udienza debba necessariamente essere fatta entro il termine, rigido e prefissato, di cinque giorni prima dell’udienza stessa previsto dall’art. 127 cod. proc. pen., comma 2, (fermo restando che, se compiuta entro questo termine, la stessa non può in nessun caso considerarsi tardiva). Non vi è invero alcun motivo per cui anche a questo proposito non debba prevalere la norma speciale dell’art. 599 cod. proc. pen. relativa al giudizio di appello, la quale non fissa alcun termine rigido per la manifestazione della volontà di comparire (cfr. Sez. VI, 9.3.1998, n. 6384, O., m. 210905). Una interpretazione che esclude l’applicabilità di tale rigido e prefissato termine, del resto, garantisce maggiormente il soddisfacimento della volontà dell’imputato di partecipare all’udienza ed appare pertanto più conforme ai ricordati principi costituzionali e di diritto internazionale pattizio.
7. Esattamente, poi, l’indirizzo giurisprudenziale qui confermato afferma che la mancata traduzione all’udienza camerale dell’imputato detenuto, che abbia richiesto di partecipare, determina, ai sensi degli art. 178 cod. proc. pen., lett. c), e art. 179 cod. proc. pen., una nullità assoluta e insanabile, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Tale conclusione si fonda sul principio (enunciato, in riferimento al procedimento di riesame ma applicabile in via generale, da queste Sezioni Unite con la ricordata sent. 22.11.1995, n. 40, C., m. 203771, e poi quasi costantemente seguito: Sez. II, 8.1.1997, N., m. 207547; Sez. VI, 16.2.1998, n. 1041, C., m. 210645; Sez. II, 6.11.2002, n. 42158, B., m. 223357; Sez. I, 16.4.2004, n. 21015, A., m. 228909; Sez. F., 30.8.2005, n. 36630, G., m. 232224; Sez. V, 27.9.2006, n. 37034, S., m. 235284; Sez. II, 20.9.2006, n. 32666, T., m. 235315; Sez. VI, 22.1.2008, n. 10319, D. B., m. 239084) secondo cui nell’ipotesi di indagato o imputato detenuto, la cui partecipazione all’udienza camerale è subordinata ad una positiva manifestazione di volontà in tal senso, l’ordine di traduzione e la sua esecuzione costituiscono, insieme con l’avviso dell’udienza camerale e la sua notificazione, atti indefettibili della procedura diretta alla regolare costituzione del contraddittorio. Senza di essi, infatti, l’avviso non può svolgere in concreto l’unica funzione che gli è propria, quella della vocatio in iudicium, che può definirsi tale solo in quanto rivolta a chi ad essa sia in grado di rispondere. Di conseguenza, la citazione dell’imputato detenuto realizza un’unica fattispecie complessa, costituita dall’avviso, dalla dichiarazione di volontà dell’interessato detenuto di comparire e dalla sua successiva traduzione, atti tutti da guardarsi, per il rapporto di stretta consequenzialità che li caratterizza, in una visione unitaria in funzione dello scopo loro proprio, la vocatio in iudicium per la valida instaurazione del contraddittorio, con la conseguenza che la mancata traduzione, perché non disposta o non eseguita, determina la nullità assoluta e insanabile della udienza e della successiva pronunzia, ai sensi dell’art. 178 cod. proc. pen., lett. c) e art. 179 cod. proc. pen..
8. Per quanto concerne il termine entro il quale deve essere manifestata al giudice la volontà di comparire all’udienza camerale d’appello e comunicato lo stato di impedimento, va poi considerato che se, per le ragioni indicate, non esiste un termine rigido e prefissato, ciò non esclude che la richiesta di presenziare debba pur sempre essere fatta – a meno che l’imputato non ne sia impedito, ad esempio per essere stato ristretto immediatamente a ridosso dell’udienza – in modo tale che sia concretamente possibile disporne ed effettuarne la traduzione per l’udienza.
Va infatti tenuto presente che l’impedimento dell’imputato si atteggia in modo diverso nel giudizio ordinario e nel giudizio camerale di appello. Nel giudizio ordinario deve sempre essere assicurata, in mancanza di un inequivoco rifiuto, la presenza dell’imputato e quindi, in virtù della norma generale fissata dall’art. 420 ter cod. proc. pen., qualora l’imputato non si presenti e in qualunque modo risulti (o appaia probabile) che l’assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, spetta al giudice disporre, anche d’ufficio, il rinvio ad una nuova udienza, senza che sia necessaria una qualche richiesta dell’imputato in tal senso.
Pertanto, qualora l’imputato sia detenuto o agli arresti domiciliari o comunque sottoposto a limitazione della libertà personale che non gli consente la presenza in udienza, poiché in tali casi è in re ipsa la presenza di un legittimo impedimento, il giudice, in qualunque modo e in qualunque tempo venga a conoscenza dello stato di restrizione della libertà, anche senza una richiesta dell’imputato deve d’ufficio rinviare il processo ad una nuova udienza e disporre la traduzione dell’imputato, a meno che, ovviamente, non vi sia stato un rifiuto dell’imputato stesso di assistere all’udienza (art. 420 quinquies). Ciò perché, specialmente in un processo a carattere accusatorio, la partecipazione dell’imputato al processo è condizione indefettibile per il regolare esercizio della giurisdizione, afferendo al fondamentale diritto di difesa, che può solo essere oggetto di una rinuncia da parte del suo titolare attraverso una non equivoca manifestazione di volontà abdicativa in tale senso.
Queste Sezioni Unite, con la sentenza 26.9.2006, n. 37483, A., hanno affermato che “non è ravvisabile, né proponibile, alcun onere (normativamente non previsto affatto) di previa comunicazione da parte dell’imputato del suo legittimo impedimento: ciò che decisivamente rileva, infatti, è solo che questo sussista – come tale conosciuto dal giudice – e che manchi una manifestazione di volontà abdicativa di quel diritto da parte del suo titolare, dovendo a quel punto il giudice prendere atto della insussistenza delle condizioni legittimanti una dichiarazione di contumacia” (punto 8.4). La detta sentenza ha quindi affermato il principio di diritto che “la conoscenza di un legittimo impedimento preclude la dichiarazione di contumacia, e solo ove l’imputato impedito esplicitamente consenta che l’udienza avvenga in sua assenza, o, se detenuto, rifiuti di assistervi, trova applicazione l’istituto dell’assenza”; e che “costituisce legittimo impedimento la detenzione dell’imputato per altra causa anche nel caso in cui questi avrebbe potuto comunicare al giudice la sua condizione in tempo utile per consentirne la traduzione” (punto 8.3). Sulla base di questi principi la predetta sentenza Arena ha ritenuto illegittima la mancata traduzione in udienza e la dichiarazione di contumacia di un soggetto detenuto per altra causa il cui stato di detenzione era stato comunicato dal difensore soltanto nel corso della stessa udienza.
9. Diversi sono invece i principi applicabili nel giudizio camerale di appello, per il quale l’art. 599, comma 2, cod. proc. pen. dispone che il legittimo impedimento dell’imputato comporta il rinvio dell’udienza soltanto allorché l’imputato abbia manifestato la volontà di comparire. Analogamente, anche l’art. 127 cod. proc. pen. (richiamato dall’art. 599) dispone ai commi 3 e 4 che l’interessato detenuto deve essere sentito sempre che ne faccia richiesta e che l’udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell’imputato che abbia chiesto di essere sentito personalmente. Nel giudizio camerale di appello, dunque, non vige la regola che l’imputato detenuto non ha alcun onere di comunicare al giudice il suo stato di detenzione, il quale di per sé, comunque risulti (o appaia probabile), determina l’obbligo del giudice di rinviare l’udienza e di disporre la traduzione, salvo esplicita rinunzia a comparire, bensì vige proprio la regola opposta, ossia che l’imputato detenuto ha l’onere di comunicare al giudice di appello la sua volontà di comparire. Nel giudizio ordinario, va sempre assicurata la presenza dell’imputato, salvo che questi inequivocamente vi rinunzi, mentre nel giudizio camerale di appello la presenza dell’imputato non è necessaria e va quindi assicurata soltanto se questi manifesti la volontà di voler comparire, potendo altrimenti presumersi la sua rinunzia ad essere presente (cfr. Corte EDU, Grande Camera, 18.10.2006, H. c. Italia). Nel giudizio camerale, pertanto, il legittimo impedimento, ivi compreso quello costituito dallo stato di detenzione, è irrilevante e non produce effetti se l’imputato non adempia l’onere legislativamente impostogli di comunicare al giudice il suo impedimento e la sua volontà di essere presente. In questo giudizio non sono di conseguenza applicabili i principi sanciti dalla citata sentenza Arena, e quindi in mancanza della comunicazione della volontà di comparire dell’imputato legittimamente impedito, il giudice non è tenuto né a disporne la traduzione né a rinviare l’udienza.
Il codice di rito dunque, in considerazione del particolare giudizio adottato, impone a carico dell’imputato detenuto un vero e proprio onere di comunicare la sua volontà di partecipare all’udienza camerale d’appello. Ciò però implica, per far sorgere il diritto, la regolarità e la tempestività dell’adempimento dell’onere, ossia che la comunicazione sia fatta con modalità tali da permettere la traduzione dell’imputato per l’udienza. Ed invero – tralasciando le ipotesi in cui non ricorre un inadempimento dell’onere per impossibilità di rispettarlo – se si consentisse che l’imputato, pur avendolo potuto fare in precedenza, possa validamente adempiere l’onere e comunicare l’impedimento e la volontà di comparire anche soltanto all’ultimo istante, quando ormai non vi sia più una corretta possibilità di effettuarne la traduzione per l’udienza, allora l’adempimento dell’onere si potrebbe trasformare in realtà in un malizioso o doloso mezzo per rinviare, senza necessità, l’udienza stessa e prolungare indebitamente la durata del processo. Il che darebbe luogo ad una interpretazione certamente non rispettosa del buon andamento processuale e non conforme al principio costituzionale della ragionevole durata del processo.
Occorre dunque pervenire ad una interpretazione che soddisfi il bilanciamento tra il diritto fondamentale dell’imputato di essere presente e la necessità di rispettare le caratteristiche di snellezza e celerità del rito prescelto dal medesimo imputato e di assicurare che la durata del processo non sia irragionevolmente e senza necessità prolungata per effetto di condotte dell’imputato maliziose o non giustificate. E tale bilanciamento sembra possa essere raggiunto ritenendo che la manifestazione di volontà dell’imputato detenuto non è soggetta ad alcun limite temporale rigido e prefissato, ma debba comunque essere considerata tardiva e non efficace quando sia stata fatta in un momento tale che, nel singolo caso concreto, non vi sia più possibilità di effettuare la traduzione per l’udienza. In tal caso, invero, può ritenersi che l’onere di comunicare la volontà di comparire non sia stato validamente adempiuto e che pertanto difetti il presupposto necessario perché abbia rilievo l’impedimento dell’imputato e perché il giudice abbia l’obbligo di assicurarne la presenza (ovvero può ritenersi – secondo l’impostazione della citata sentenza H. c. Italia della Corte EDU – che legittimamente il giudice può ravvisare nel comportamento dell’imputato una rinuncia a comparire).
Non potrebbe invece riscontrarsi un inadempimento dell’onere (con le dette conseguenze) allorché vi sia stata una oggettiva impossibilità di effettuare prima la comunicazione (come, ad esempio, quando la detenzione intervenga nell’immediata prossimità dell’udienza). In questo caso, così come in quello in cui la traduzione, pur oggettivamente possibile, non è avvenuta per disguidi o ritardi dell’amministrazione, dovrà essere disposta la traduzione per una successiva udienza.
Poiché, però, si tratta pur sempre del diritto fondamentale dell’imputato detenuto di essere presente nell’udienza in cui si decide della sua responsabilità e del trattamento sanzionatorio, il principio appena enunciato deve poi essere interpretato ed applicato in modo rigido, sia nel senso che la richiesta potrà ritenersi tardiva soltanto allorché in concreto non vi sia possibilità pratica di assicurare la presenza in udienza dell’appellante, sia nel senso che il giudice, qualora ritenga intempestiva la richiesta, deve dar conto, con adeguata e congrua motivazione, delle specifiche ragioni per le quali in quel determinato caso non era possibile effettuare la traduzione dell’imputato in udienza, prendendo in considerazione tutte le specifiche circostanze del caso concreto, quali, ad esempio, il tipo di limitazione della libertà personale, il luogo in cui l’imputato si trova ristretto, e così via. È infatti evidente che diverso è il caso in cui l’imputato sia detenuto in carcere in un’altra città da quello in cui sia agli arresti domiciliari nella stessa città, sicché diversa deve essere la valutazione circa la eventuale tardività della richiesta.
10. Sembra opportuno precisare che i principi qui affermati si applicano non solo nel caso in cui l’imputato sia detenuto in un istituto penitenziario, ma anche quando si trovi agli arresti domiciliari o sia comunque soggetto ad altra misura restrittiva della libertà personale che non gli permette di presentarsi liberamente all’udienza.
Deve invero qui ricordarsi che, secondo un indirizzo giurisprudenziale – relativo soprattutto al giudizio ordinario – anche di recente ribadito da alcune decisioni, l’imputato sottoposto ad arresti domiciliari per altra causa, qualora intenda comparire in udienza, avrebbe l’onere di chiedere tempestivamente al giudice competente l’autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per il tempo necessario, non essendo, in tal caso, configurabile un obbligo dell’autorità giudiziaria procedente di disporne la traduzione (Sez. II, 24.4.2008, n. 21529, R., m. 240107; Sez. V, 14.11.2007, n. 44922, G., m. 238505; Sez. IV, 13.5.2005, n. 28558, B., m. 232436; Sez. V, 15.11.2002, n. 7369/03, G., m. 224859; Sez. V, 2.2.2001, n. 13184, P., m. 218391; Sez. VI, 30.4.1997, n. 7319, P., m. 209739; Sez. I, 22.5.1996, n. 5606, M., m. 204859).
A sostegno di questa tesi si afferma che gli arresti domiciliari (o altre limitazioni della libertà) non costituirebbero una situazione di “assoluta impossibilità di comparire” perché l’imputato potrebbe chiedere al giudice competente la rimozione dell’impedimento ed avrebbe quindi l’onere di rivolgersi a tale giudice; che l’imputato avrebbe anche l’onere di manifestare al giudice che procede una espressa volontà di partecipare; che, ai sensi dell’art. 22 disp. att. cod. proc. pen., comma 1, è il giudice della cautela o il magistrato di sorveglianza ad avere il potere di autorizzare l’allontanamento o disporre l’accompagnamento o la traduzione, mentre il giudice che procede non ha la disponibilità dello stato di libertà del soggetto.
Questo indirizzo non può però essere condiviso.
Innanzitutto, esso è stato ormai chiaramente superato dalla citata sentenza Arena di queste Sezioni Unite, che ha affermato che la detenzione per altra causa costituisce legittimo impedimento anche quando l’imputato avrebbe potuto avvisare il giudice della sua condizione in tempo utile per consentire la traduzione ed ha escluso che l’imputato detenuto abbia un onere di chiedere al giudice competente la rimozione dell’impedimento o di comunicare al giudice che procede la sua volontà di essere presente, avendo rilievo soltanto il fatto che il giudice abbia comunque conoscenza di una obiettiva situazione di impedimento e la mancanza di una esplicita rinunzia a comparire.
In ogni caso, non appare possibile subordinare l’esercizio di un diritto fondamentale, come quello di partecipare al processo, ad oneri che non siano espressamente previsti da una disposizione legislativa.
Non può poi dubitarsi che nei casi di restrizione della libertà personale diversi dalla detenzione in carcere sussista ugualmente un legittimo impedimento, giuridico se non materiale, che non si differenzia, agli effetti che qui interessano, dall’impedimento costituito dalla detenzione in carcere. Né può ritenersi che in tal caso l’impedimento non sarebbe più legittimo ed assoluto solo perché l’imputato potrebbe chiedere l’autorizzazione o l’accompagnamento o la traduzione al giudice competente. Riesce infatti difficile comprendere quale differenza vi sarebbe, a questi fini, tra imputato detenuto in carcere ed imputato agli arresti domiciliari, dato che anche il primo potrebbe rimuovere l’impedimento chiedendo al giudice competente la traduzione dinanzi al giudice che procede, onere questo che invece è stato assolutamente escluso dalla citata sentenza Arena. Si dovrebbe quindi giungere alla conclusione – certamente non accettabile – che lo stato di detenzione per altra causa non costituirebbe mai un impedimento legittimo ed assoluto perché l’imputato potrebbe sempre rivolgersi per rimuoverlo al giudice competente sulla sua libertà. D’altra parte, è già stato esattamente rilevato che un diverso trattamento nelle due ipotesi non avrebbe ragione, perché un allontanamento abusivo produrrebbe in entrambi i casi gli stessi effetti e perché non potrebbe essere nemmeno giustificato dalle diverse condizioni di restrizione, “in quanto, anzi, sotto il profilo della comunicazione con il giudice competente il detenuto è facilitato, potendo utilizzare per ogni comunicazione con l’autorità giudiziaria la direzione del carcere (con il relativo ufficio matricola), mentre non necessariamente il detenuto agli arresti domiciliari può avere a propria disposizione un telefono, o persone in grado di agire al suo posto e, quindi, trovarsi in grado di comunicare altrettanto facilmente con il proprio giudice” (Sez. I, 13.2.2001, n. 13593, M.).
È poi irrilevante il richiamo all’art. 22 disp. att. cod. proc. pen., perché il secondo comma di questo articolo prevede espressamente che la traduzione può essere disposta dalla autorità giudiziaria dinanzi alla quale la persona deve comparire.
Deve pertanto essere confermato il principio, già da tempo enunciato, che “colui il quale viene ammesso al regime degli arresti domiciliari si trova, pur sempre, in stato di detenzione, cioè di privazione della libertà personale e può lasciare il luogo di arresto domiciliare solo previa autorizzazione del magistrato competente o per disposizione dello stesso che deve, in tal caso, ordinarne la traduzione. Pertanto se il giudice ha tempestiva conoscenza del fatto che l’imputato trovasi – per altro procedimento penale – in stato di arresti domiciliari, non può dichiararne la contumacia, ma deve disporne la traduzione in aula” (Sez. I, 5.3.1990, n. 5164, T., m. 183950), e che “l’imputato che si trovi agli arresti domiciliari per altra causa e nei cui confronti, essendo nota al giudice procedente tale sua situazione, non sia stata disposta la traduzione, è da considerare legittimamente impedito a comparire e non può, quindi, essere dichiarato contumace” (Sez. I, 13.2.2001, n. 13593, M., m. 218806; nello stesso senso. Sez. II, 7.11.2002, n. 41252, V., m. 223498; Sez. IV, 14.2.1991, n. 5834, M., m. 187279).
Non vi sono poi ragioni per ritenere che questo principio non debba valere anche nel giudizio camerale di appello ex art. 599 cod. proc. pen.. In questo giudizio, infatti, l’onere imposto all’imputato soggetto a misure restrittive della libertà personale (anche diverse dalla detenzione in carcere) perché sorga il suo diritto di essere presente in udienza è sempre e soltanto quello di far pervenire, in qualunque modo ma per tempo, al giudice di appello la manifestazione della sua volontà di partecipare. Non sono normativamente previsti altri oneri, ivi compreso quello di rivolgersi previamente al giudice della cautela o al magistrato di sorveglianza, mentre una interpretazione estensiva o una applicazione analogica che portasse a configurare un onere del genere non sarebbe giustificata da dati normativi o da decisive ragioni pratiche e sarebbe comunque non conforme ai ricordati principi costituzionali e pattizi. Deve dunque ribadirsi che, anche nel giudizio camerale d’appello, l’imputato soggetto a misure restrittive ben potrà rivolgersi al giudice competente per chiedere l’autorizzazione a recarsi in udienza o l’accompagnamento o la traduzione, ma se ciò non abbia fatto o se il giudice competente non abbia accolto la richiesta, il giudice d’appello che procede – sempre che gli sia comunque pervenuta a tempo la manifestazione di volontà dell’imputato di essere presente – non può comunque celebrare l’udienza ma deve disporre la traduzione (cfr. Sez. II, 9.1.2003, n. 11756, B., m. 224905, in relazione ad imputato agli arresti domiciliari; Sez. VI, 29.1.2002, n. 21561, B., m. 222742, e Sez. VI, 9.3.1998, n. 6384, O., m. 210906, in relazione ad imputato soggetto all’obbligo di dimora in un comune diverso).
11. Nel caso in esame, l’imputato appellante era soggetto agli arresti domiciliari nella stessa città di Napoli ed aveva richiesto alla corte d’appello per i minorenni di Napoli di essere presente alla udienza del 15 gennaio 2009 per mezzo di fax inviato e pervenuto il 14 gennaio 2009, alle ore 16:27, allegando peraltro che nell’avviso dell’udienza notificatogli non era indicata la sua facoltà di chiedere di comparire.
La corte d’appello, con l’ordinanza emessa in udienza, ha rigettato la richiesta per due motivi: innanzitutto perché si trattava “di processo in camera di consiglio per il quale l’imputato avrebbe dovuto chiedere tempestivamente di essere presente”. Stante la genericità della affermazione, che non indica la ragione della intempestività, l’unica interpretazione possibile è che l’ordinanza abbia voluto fare implicitamente richiamo all’orientamento giurisprudenziale, dianzi ricordato, secondo cui la richiesta avrebbe dovuto essere fatta fino a cinque giorni prima dell’udienza, rispettando il termine di cui all’art. 127 cod. proc. pen., comma 2.
Si tratta di una tesi che, per le ragioni dianzi indicate, non può condividersi, sicché questo primo motivo di rigetto è infondato.
Il secondo motivo di rigetto è che “il fax è pervenuto solo alle ore 16.26 del 14.1.09 e che non è stato pertanto possibile disporre l’autorizzazione ad essere presente”. L’affermazione è però del tutto apodittica e si risolve quindi in una motivazione meramente apparente, perché non viene spiegato per quale ragione, pur essendo pervenuta la richiesta dell’imputato nel pomeriggio del giorno precedente e pur avendone dunque la corte d’appello avuta notizia al più tardi nella prima mattina del giorno seguente, prima dell’inizio dell’udienza, e pur trovandosi l’imputato agli arresti domiciliari nella medesima città, non era possibile disporne ed effettuarne l’immediata traduzione, eventualmente differendo l’udienza alla fine dalla mattina, se non nel pomeriggio. D’altra parte nemmeno risulta che gli organi di polizia compenti non fossero in grado di eseguire durante la mattinata una traduzione nella stessa città, dal momento che la corte d’appello non ha nemmeno compiuto il tentativo di assicurare la presenza in udienza dell’imputato, disponendone comunque la traduzione.
Stante la totale mancanza di motivazione sulla tardività della richiesta dell’imputato agli arresti domiciliari di comparire per impossibilità di eseguire la traduzione, è illegittima l’ordinanza con la quale la richiesta è stata respinta ed è stata disposta la prosecuzione del giudizio nonostante la mancata traduzione. Ne consegue la nullità del giudizio di appello e della sentenza impugnata, la quale va dunque annullata con rinvio ad altra sezione della corte d’appello di Napoli per nuovo giudizio.
Gli altri motivi di ricorso restano assorbiti.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della corte d’appello di Napoli per nuovo giudizio.
[OMISSIS]